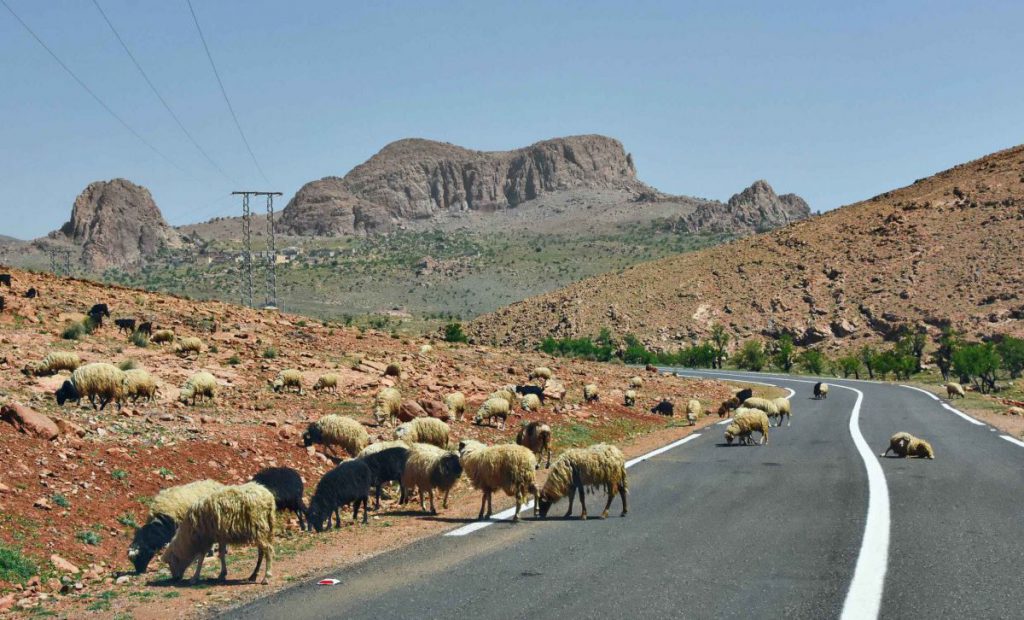Dalla Russia: la Gallina Orloff
La gallina di razza Orloff è una razza avicola proveniente dalla Russia e diffusa anche in molti altri paesi.
Si presentano con un aspetto maestoso ed elegante, con numerose sfumature nel piumaggio, tipiche nel loro genere.
Per quanto riguarda le sue origini, queste sono radicate nella provincia di Gilan, nel nord dell’Iran dove a quel tempo era molto conosciuta la razza Chilianskaia. La teoria più accreditata dagli studiosi, circa l’origine della razza Orloff, ritiene che alcuni esemplari della Chilianskaia furono portati dalla provincia di Gilan fino a Mosca, in dono al conte Alexei Grigoryevich Orloff Techesmensky e che da queste si sia poi originata la razza ribattezzata come Orloff proprio in onore del loro nobile possessore.
Successivamente fino agli anni ’70, la razza Orloff è stata conservata separatamente nell’URSS e nella RDT, quindi ora possiamo considerare diversi rami indipendenti della razza Orloff, la tipologia russa e la tipologia tedesca, perché gli standard di razza tedeschi differiscono da quelli russi.
Oggi, dopo gli eventi storici delle due Guerre Mondiali e i successivi cambiamenti socioeconomici, la razza Orloff è considerata gravemente a rischio di estinzione.
La caratteristica più importante, specialmente negli esemplari maschi, è il piumaggio facciale che è caratterizzato dai favoriti uniti e dall’abbondante barba che ricopre tutto il corpo.
È una razza molto rustica che resiste senza difficoltà alle temperature più fredde, infatti, è in grado di deporre uova anche negli inverni più rigidi.
Ha il collo robusto e arcuato, i bargigli piccoli, il becco scuro e curvo e il volto rossastro, con gli occhi leggermente infossati. I polli Orloff sono barbuti, hanno zampe gialle e cresta a cuscinetto. Esistono in tre varietà di colore: rosso, bianco e chiazzato.
L’espressione di questa gallina è spesso descritta come “cupa” e “vendicativa” ma nonostante le loro fattezze possano farla assimilare a qualche possente razza combattente, sono in realtà animali dal temperamento mansueto. Le galline di razza Orloff hanno infatti un temperamento molto attivo e vigile e al tempo stesso sono fiduciose e indipendenti. Dedicandogli un’attenzione regolare risultano molto mansuete e facilmente gestibili.
Amano gli ampi spazi, ma possono essere allevate anche in spazi più ridotti, pur sempre con disposizione di pascolo dove poter razzolare, come ad esempio in un giardino.
Producono circa 160-180 uova/anno di colore marrone chiaro e le chiocce sono ottime madri.